Solo un altro blog targato WordPress…per riflettere sui fatti della città
Il nostro futuro è l’economia della conoscenza
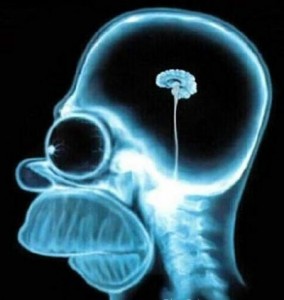 di Paolo Scattoni
di Paolo Scattoni
Il dibattito su Chiusinews non è, e non può essere limitato al problema elettorale. Dobbiamo utilizzare Chiusinews anche per guardare alla nostra comunità con uno spirito meno polemico e rivolto alle prospettive future. Dieci anni fa l’Unione Europea, guidata allora da Romano Prodi, mise a punto la cosiddetta strategia di Lisbona. L’obiettivo espressamente dichiarato era quello di fare dell’Unione la più competitiva e dinamica economia della conoscenza entro il 2010. Quell’obiettivo non è stato raggiunto, ma rimane ancora valido.
E’ chiaro a tutti che il progresso economico non può più basarsi prevalentemente sulla produzione di merci, quanto piuttosto di beni e servizi ad alto contenuto di conoscenza. D’altra parte in questi ultimi anni appare chiaro a tutti che stiamo vivendo in una grande rivoluzione imposta dai progressi delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni. In questo momento state leggendo un articolo scritto su una sorta di quotidiano locale che vi arriva tramite la rete. Costa quasi niente, ma raggiunge una buona sezione della comunità locale. La sua qualità è data dalla conoscenza e dall’intelligenza di chi vi partecipa. Per ora riguarda soltanto una parte delle famiglie (circa il 50%) ma si può ipotizzare che in pochi anni avrà una diffusione pari a quella del telefono (in Danimarca sono già all’80%). La strategia di Lisbona è stata pensata per grandi aggregati. Alcuni studiosi hanno ipotizzato uno sviluppo basato sulla conoscenza per le grandi aree urbane. 
Possiamo pensare che anche piccole realtà come la nostra possano delineare strategie su questa base? Io credo di si. Nei nostri dibattiti abbiamo visto quale grande opportunità sia rappresentata dalla riorganizzazione dell’istruzione superiore a Chiusi. L’importante dovrà essere il collegamento con il mondo della produzione. Occorre pensare al ruolo in declino dell’industria edilizia, mentre si dovranno favorire quelle ad alta tecnologia che pure nel nostro comune esistono.
Nei nostri dibattiti su Chiusinews abbiamo visto come diverse reltà organizzate (LUBIT, Università popolare, Teatro, etc.) ma anche singole persone di ottimo livello potrebbero essere inserite in questo disegno. Credo anche che una realtà come la nostra dovrebbe cercare un rapporto con le università. Le turbolenze di queste ore riguardano i pro e i contro sul ritorno della nostra unversità sui modelli di trent’anni fa. In fondo niente di preoccupante, perché quel modello è destinato ad essere travolto proprio dalla rivoluzione tecnologica in atto.
Vale però la pena pensare di mettere in „rete“ queste diverse realtà per una strategia locale basata sulla conoscenza che non necessariamente passerà più per i canali tradizionali. Dobbiamo quindi partecipare con rigore alle attuali vicende per le elezioni amministrative, ma non dobbiamo però prendercela poi tanto, perchè il futuro, che è già in cammino, pare seguire anche altre starde.
| Stampa l'articolo | Questo articolo è stato pubblicato da lucianofiorani il 22 dicembre 2010 alle 00:07, ed è archiviato come CULTURA, ECONOMIA, POLITICA, SCUOLA. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso RSS 2.0. Sia i commenti sia i ping sono disattivati. |
I commenti sono disattivati.
circa 14 anni fa
Enzo, hai ragione, il terma però non è semplice ed è difficilmente supportabile con esperienze consolidate. Certamente avremo modo per riparlarne.
circa 14 anni fa
Caro Paolo, se non si fa polemica non si ottiene attenzione. Dove sono tutti quei soloni delle “questioni aperte” e dei nomi che non piacciono? Qui si parla di scuola, tecnologia, futuro, sapere e soldi, eppure non c’è un insegnante che abbia detto “ba” o un laureato – cioè qualcuno che “c’è già passato” – che abbia detto che stiamo completamente sbagliando.
Ok, sarà per un altro thread
circa 14 anni fa
Certo la soluzione ideale sarebbe quella della fondazione. Ma all’inizio si potrebbe procedere con strumenti più semplici.
circa 14 anni fa
Si, avevo capito bene: la tua idea è che diventi sistema quello che oggi è intuizione geniale ma estemporanea. E siamo d’accordo. Il problema è che la rete, per diventare sistema, ha necessità di una infrastruttura affidabile con operatori motivati. Per esempio: Alla proposta politica statunitense (anche l’esercito americano si è convertito al “verde” – articolo su Repubblica di qualche giorno fa) di investimento su energie verdi e rinnovabili (in cui noi italiani siamo avanguardia), che richiede una scuola di formazione di eccellenze, un meccanismo di salvaguardia delle imprese attraverso un credito accessibile, un quadro burocratico efficiente con cui salvaguardare sia gli investimenti sia la stabilità dell’azione amministrativa, abbiamo la risposta nucleare, con un progetto di disarticolazione della scuola e una vera persecuzione nei confronti di strutture burocratiche che potrebbero invece essere ben indirizzate se irrobustite e fornite delle necessarie certezze. Inoltre, non c’è nessun accenno a politiche di incentivo per l’accesso al credito per investimento. E’ chiaro che una proposta localistica nasce un po’ asfittica. Eppure, gli spazi ci sarebbero: parziale defiscalizzazione per imprese che sperimentino progetti di eccellenza prodotti dalla scuola locale (con piani di fattibilità e tempi di realizzazione), i progetti potrebbero essere brevettabili dalla scuola per conto dello/degli studenti (quindi, magari con costo brevetto pari a zero e monetizzabile dalla scuola stessa per diciamo 3 anni; dopo di che, gli studenti che lo hanno prodotto ritornano titolari dei diritti sui brevetti – con relativi ritorni economici -). Credo che potrebbe essere un modo per far fare un salto in avanti a tutto il sistema scolastico locale che troverebbe stimoli e motivazioni nuove. L’industria potrebbe essere interessata perché avrebbe ritorni senza praticamente investimenti. Bisognerebbe magari affrontare il tema su uno spazio meno angusto del blog.
circa 14 anni fa
In effetti l’articolo è molto sintetico rispetto a tutto quello che si poteva dire. Con un esempio forse riesco a spiegarmi meglio. A Chiusi esiste un’impresa che produce impianti per la produzione di traversine ferroviarie ad alto livello di automazione che riesce ad esportare in varie parti del mondo. Credo che lavori con un brevetto prodotto in casa. Con la crisi aveva messo la quasi totalità dei dipendenti in cassa integrazione, ma è stata una delle prime a riprendersi.
Mi sono sempre chiesto come sia nato quel brevetto che oggi garantisce il lavoro a diverse decine di dipendenti. E’ possibile mettere in rete la scuola con la produzione per creare le condizioni perché possa emergere elaborazione di conoscenza di quel tipo?
Mettere in rete non significa necessairmente internet (che è solo un mezzo) ma un’organizzazione che crei un “ambiente” in cui l’innovazione sia più facile.
Come ho scritto nell’articolo ci sono esperienze che riguardano le grandi città (Cleveland è l’esempio classico) che sono state in qualche maniera codificate. La mia domanda è: è possibile trovare un percorso anche per i piccoli centrio come Chiusi?
circa 14 anni fa
Sono d’accordo con Paolo. Occorre però avere chiare due cose (e mi riservo di re-intervenire al proposito): da un lato la necessità di avere dei punti fermi circa la conoscenza. Ci sono aspetti che non siamo in grado di controllare (penso ai protocolli di verificabilità degli esperimenti della fisica contemporanea: in teoria, l’esperimento è ripetibile, il problema è come e da chi; ma lo stesso vale per l’indagine rivolta a tutti quei problemi con classi di complessità che in informatica sono note come NP-complete; o la teoria delle stringhe, e via andare) e che quindi richiedono un lavoro di formazione possibile solo per certe strutture e in determinate condizioni. E’ chiaro che, quale che sia il settore in cui entriamo, la produzione/riproduzione della conoscenza “certificata” è o, meglio, considerata la presenza di certi funesti ministri, dovrebbe essere un dovere dello Stato e dell’istituzione. Per cui concordo con te che la “diffusione” del sapere è un fatto reale (ad es., il tuo lavoro sul paesaggio nella maremma toscana è possibile consultarlo anche a chi, come me, non è un esperto in materia; quanto al comprenderlo, temo che sia un altro discorso), ma la diffusione non è produzione di conoscenza (altro esempio: se non so disegnare, il mio computer – seppur attrezzatissimo – non saprà farlo per me). Qui era la scommessa di Prodi e di Lisbona: produrre sapere di qualità. C’è anche un altro aspetto su cui sorvoli ma che è cruciale: il sapere che circola quanto è garantito? L’onestà dei partecipanti al blog è fuori discussione, eppure, in buona fede, potrebbe essere fatta un’affermazione o veicolata una notizia infondata e potremmo esserne influenzati tutti, magari solo perché l’autore è autorevole
L’altro aspetto è che ormai il locale non esiste più o, meglio, esistono problemi locali indotti dalla dimensione globale di tutto quello che avviene (il famoso battito d’ali di farfalla in Brasile che genera i monsoni in India). Dal punto di vista che hai disegnato (di reti di computer che consentono larga circolazione di informazioni), locale è solo una modalità del mondo, cioè è solo ciò che posso vedere in questo momento (la finestra che da’ sul Botusso oppure l’interconnessione in chat con i miei amici tra Spagna, Francia e Messico). E dato che, come dicono gli americani, nessun pasto è gratis, occorre capire quanto costa e chi paga per questa nostra dimensione. E’ la strage del sud del mondo e il dramma della delocalizzazione: come sempre, non c’è festa senza sofferenza di qualcuno.